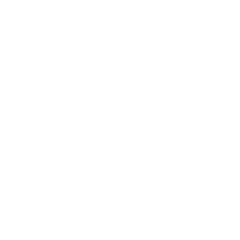La spada del Samurai
Terminologia e nomenclatura delle armi bianche giapponesi. La terminologia e la nomenclatura riguardante le varie fogge d’armi bianche, un tempo in uso nel Giappone feudale, sono circostanziate e precise fino ad un punto quasi inconcepibile per la mentalità e le abitudini occidentali. A parte la gran divisione dimensionale in daì-tô, o spade lunghe, in shô-tò, o spade corte e in tan-tô, o pugnali,i giapponesi si distinguono le prime in tachi e in katana. Il tachi costituì fino all’era Oeì (1394-1427) l’arma tipica da combattimento, ed era montata in modo che nella sua posizione normale di riposo, la lama si trovasse nel fodero col taglio verso il basso, in modo analogo all’uso europeo di portare la sciabola.
Dopo l’era Oeì, il tachi fu usato prevalentemente come arma da cerimonia e non subì altre variazioni o perfezionamenti, se non a proposito del vario stile di decorazione della montatura (koshirae), assunse spesso, nei secoli seguenti, una ricchezza particolare. Dopo questo periodo, l’autorizzazione a portare armi bianche in pubblico venne regolata da precise disposizioni. Nel periodo Edo, e in altre parole fra il 1600 circa e il 1877 (anno nel quale un rescritto sovrano inibì il porto d’armi ai civili) la nobiltà, i daimyô (signori feudali) e i samurai (classe dei militari professionali, formante il corpo delle armate private dei nobili e dei daimyô) potevano portare due sciabole alla cintura, il cui complesso era detto daì-shô (lett. grande e piccola). La sciabola lunga (dai-tô) era nota sotto il nome di katana; la più corta (shô-tô) è talvolta chiamata anche wakizashi o han-dachi (mezzo tachi), secondo le particolarità della montatura. Nei primi anni dello shogunato Tokugawa (circa il 1600), anche i commercianti della categoria superiore furono autorizzati a portare la sciabola, ma solo quella corta (wakizashi).
La nomenclatura delle varie parti e particolarità della lama e della montatura delle armi bianche giapponesi (tô) è talmente minuta e dettagliata che una sia pur sommaria descrizione comporterebbe un impegno inconciliabile con la tirannia dello spazio. D’altro canto, la nomenclatura delle varie parti costituenti la montatura, o koshirae, è l’unica ad essere se pur sommariamente nota anche ai raccoglitori occidentali. Fra queste parti rammenteremo: la guardia (tsubasa); l’impugnatura di pelle di pescecane (samekawa), col suo pomello terminale (kashira), i suoi due ornamenti mediani (menuki) e il suo anello di guardia (fuchi); il coltellino (kozuka) e quel curioso arnese, simile ad un tagliacarte (kôgai) che in realtà non è che una sorta di spillone crinale, atto rifare quel nodo di capelli, o mazzocchio, che costituiva una delle caratteristiche del costume nobiliare giapponese. Sull’uso del kozuga si può precisare che, non possedendo l’abito classico giapponese alcuna tasca, l’unico ricettacolo comodo e sicuro per conservare un coltellino era costituito, infatti, dal fodero delle inseparabili lame, ed in particolare della più corta delle due, che veniva portata indosso anche durante le visite, contrariamente alla lunga (katana), per solito veniva deposta all’ingresso, in un’apposita rastrelliera, detta katana-kake. In ragione della sua minor lunghezza e maneggevolezza, la tan-tô o il wakizashi erano le armi solitamente impiegate per il rito del suppuku, o suicidio onorevole, noto in Europa come harakiri (lett. taglio ombelicale). È comunque erroneo credere che questo fosse lo scopo solo ed essenziale del tan-tô. L’unico esempio noto, era quello costituito da uno speciale pugnale, del quale erano dotati i famosi kami-kaze (lett. vento divino) o aviatori suicidi, dell’ultima guerra mondiale. La caratteristica della mentalità giapponese non si è limitata alla minuziosa nomenclatura delle varie parti costituenti la montatura delle armi nazionali. Questa parte, che è l’unica che gli occidentali generalmente apprezzano per i suoi evidenti aspetti artistici, non rappresenta per l’amatore giapponese, e tanto meno lo rappresentava per l’antico samurai, se non un abito esteriore, talvolta certo pregevole, ma non comparabile al valore del materiale e artistico della lama, che è stata considerata sempre come la vera “anima spirituale” dell’arma. Le lame più pregiate sono, infatti, abitualmente conservate in Giappone in un astuccio-fodero di legno bianco di magnolia (shira-saya), privo di qualsiasi decorazione, onde non distrarre l’attenzione dell’intenditore con elementi decorativi estranei al puro fatto artistico, costituito dalla lama. La minuzia con la quale un intenditore giapponese considera una lama di nobile fattura; la precisione e il dettaglio con la quale ne distingue e ne definisce le parti; la colorita aggettivazione, propriamente artistica, con la quale ne pone in rilievo i pregi di tempra o di forma; l’abilità con la quale sa apprezzare e valutare a colpo d’occhio la scuola, la bontà della fucinatura, l’età e perfino il colore assunto dal tesissimo e specchiante acciaio (spesso definito di colore “profondo e sereno”), costituiscono veramente motivo di meraviglia anche agli occhi “occidentali”, di chi possa essere considerato qualcosa più di un dilettante in questa materia.
A differenza di quanto si osserva nel caso delle armi occidentali, dal periodo classico fino ai tempi più recenti, gli esperti giapponesi dispongono di termini appropriati e precisi per tutte le varie forme di dimensione delle lame, e ciò trova le sue origini e la sua giustificazione nell’isolamento storico che per molti secoli protesse il Giappone dal contatto con altri popoli e con diverse civiltà. In questo modo, mentre da un lato crebbe e si radicò nel popolo di Yamato l’amore per le tradizioni e il culto delle memorie, non distratti o sviati da mode e da fogge estranee: dall’altro, diede modo e materia agli artefici di esercitare le loro facoltà in una lenta ma continua opera di perfezionamento intrinseco, operando su forme esteriori che la tradizione appuntamento aveva reso quasi immutabili. Per questo motivo, non è difficile trovare montante su koshirae del XIX secolo delle lame fabbricate magari tre o quattro secoli prima; tanto più che, come s’è detto, gli amatori giapponesi ammetto ben poca importanza alla montatura di un’arma che, proprio come una veste, poteva essere cambiata più volte che le circostanze, il gusto personale o la moda consigliavano. Si deve probabilmente a questo criterio il fatto che le sciabole giapponesi consentano di smontare e rimontare la lama con la semplice espulsione o inserzione di un solo piccolo perno conico di legno (mekugi), che trova alloggio in un foro attraversante l’impugnatura di legno, coperta di pelle di pesce-cane(samekawa) e di nastro intrecciato (tsukaito), e contrastata lievemente in un analogo foro (mekugi-ana), praticato nel largo codolo (nakago).
Traccia di quest’abitudine, di mutar spesso a piacere l’aspetto esteriore di un’arma, si ritrova nelle lame giapponesi più antiche e pregevoli, che frequentemente presentano appunto due o più fori nel codolo, indice di successivi adattamenti a diverse koshirae. Troppo lungo sarebbe in questa sede un accenno anche sommario alla nomenclatura di una lama giapponese. Basti affermare che per le sole figure di tempra (yakiba), che appaiono normalmente per azione della brunitura sulle due facce dell’angolo dietro (jihada) costituente il tagliente di una lama (mono-uchi), esistono almeno trenta denominazioni peculiari: dal tipo più semplice hoso suguha (lett. “stretto-dritto”) ai più complessi, sanbonsugi (lett. “tre cedri”), e kikusui (lett. “crisantemo che galleggia sull’acqua”). Fucinatura e tempra Come un opera d’arte, quale viene dai competenti considerati una lama giapponese di appena non volgare fattura, deve portare incisa sul codolo la firma dell’autore per solito accompagnata dalla data e dal luogo di fabbricazione.
La precisione è spinta talvolta fino all’indicazione del mese e del giorno, questa pratica ricollegandosi evidentemente a talune superstiziose credenze, relative all’influenza delle stagioni sulla riuscita dell’operazione di tempra o di fucinatura.
Tradizionalmente, l’operazione di tempra doveva essere compiuta quando “il giorno è fresco e sereno, l’aria è dolce e calma e l’artefice è ben composto nella mente e nel corpo”. Le lame più pregiate possono essere sottoposte all’esame di un esperto, che rilascia un documento d’autenticità (origami). Il valore che possono raggiungere le lame giapponesi, di buona scuola, sui mercati locali, è enorme, quasi inconcepibile alla mentalità europea. Una lama di Masahide era valutata ventimila Yen in un catalogo del 1935, quando lo Yen valeva ¼ di dollaro USA.
Esistono lame firmate da Amakuni, da Munechika o da Sanemori, valutate venticinquemila Dollari USA, e altre più recenti, di Tadayoshi o di Yasutsuga, valutate oltre dodicimila Dollari USA (sempre al cambio del 1935!). Queste eccezionali quotazioni sono del resto giustificate dal fatto che i più celebri artefici impiegavano talvolta due o più anni di tempo per portare una lama a finimento, e che molti di loro non giunsero a produrre, in tutta la loro vita, più di venti o trenta lame, di più, distruggevano completamente tutti gli esemplari imperfetti, o in ogni caso non vi apponevano la loro firma. Come qualunque altra lama di funzionale efficienza, dalle etrusche alle rinascimentali, quella giapponese non è fabbricata da un solo massello d’acciaio omogeneo; essa è invece costantemente da una ragionata alternazione di strati d’acciaio duro e d’acciaio dolce o dolcissimo, sapientemente saldati per fucinatura. Si tratta quindi anche in questo caso, di quelle lame che noi chiamiamo di damasco saldato a strati, in mancanza di un termine italiano meno equivocabile. L’acciaio più duro (uagane) forma la parte esterna e il tagliente; quello più dolce (shintetsu), la parte interna o cuore. Le maggiori cure dell’artefice erano naturalmente dedicate all’elaborazione dell’uagane; per la preparazione della quale, ogni singola scuola seguiva segrete norme sue peculiari. In ogni caso, tuttavia, l’artefice partiva da una piastra d’acciaio corburato (dikane) di circa 75×125 mm, sulla quale veniva saldata a martello, al color rosso, una conforme piastra di fero (tamahagane). Ogni calda era preceduta da un’aspersione con una miscela (uchiko) d’argilla e di polvere di carbone di legna, sia allo scopo di evitare l’ossidazione superficiale che, probabilmente, per carburare ulteriormente il materiale. Quest’ultima considerazione viene dal fatto che per la preparazione del shintetsu, che deve necessariamente essere più dolce, gli artefici impiegavano generalmente un’assai minor quantità della predetta miscela. La lavorazione procedeva quindi per successive calde e distensioni al martello fino ad ottenere un piatto largo e sottile, perfettamente uniforme: ad ogni calca precedeva un’aspersione con ceneri di rovo. A questo punto, il piatto era inciso sulla mezzeria trasversale, piegato su se stesso e saldato nuovamente. Questa operazione era
ripetuta fino a 18 o 20 volte consecutive, risultandone una struttura a sottilissimi strati alterni, perfettamente saldati e privi di scorie incluse, che le successive martellature consentivano di espellere, allo stato fluido, della compagine metallica, resa pastosa dal calore. A parte, un’analoga operazione, ripetuta generalmente un minor numero di volte (8-12), era condotta su un massello di ferro dolce, per la preparazione della parte centrale (shintetsu) della lama.
Finalmente, l’uagane era ripiegato al shintetsu e il tutto veniva saldato al martello sbozzato nella forma grossolanamente finale. Seguiva una più precisa sagomatura a lima o a pietra abrasiva, fino alla misura quasi definitiva della lama, e si procedeva finalmente all’operazione di tempra.
La modalità secondo la quale l’operazione di tempra era condotta, onde ottenere le caratteristiche figure (yakiba) del tagliente, non sono tuttora ben note.
È probabile che la lama, nella sua forma definitiva, venisse avvolta da un impacco d’argilla refrattaria; prima di portare il tutto alla temperatura di tempra quest’impacco plastico era assottigliato con uno strumento affilato, in corrispondenza del tagliente, in maniera di ripetere il disegno desiderato dello yakiba. Il successivo riscaldamento a cuore consolidava l’argilla, e l’immersione nel mezzo di tempra (acqua) agiva più o meno drasticamente sulla velocità di raffreddamento, secondo lo spessore dell’impacco, refrattario e poco conduttore. In altre parole, mentre l’acciaio riusciva a tutta tempra nelle parti meno isolate dall’impacco (perché ad arte assottigliate), in quelle più protette da un maggior spessore d’argilla, la temperatura era più attenuata, fino a risultare pressoché nulla verso la costola esterna della lama (mine). Sta comunque il fatto che uno studio metallografico veramente conclusivo sulla struttura delle lame giapponesi sì buona scuola è ben lungi dall’essere compiuto, sebbene scienziati di chiara fama vi abbiano esercitato a lungo l’ingegno.
(da “Una pregevole lama giapponese di Masashide” di Carlo Pensieri)